
Qualche mese fa mi aggiravo nel museo di un antico castello di Cracovia. In uno dei piani erano esposte delle armature del sedicesimo secolo, appartenenti a dei soldati a cavallo ussari, in perfetto stato, mai usate. Nonostante il materiale fosse davvero strepitoso, con decorazioni fatte a mano e imponenti ali di stoffa cucite sul retro, si trattava di oggetti abbastanza ordinari: non appartenevano a collezioni pregiate o alla nobiltà, bensì a cavallerizzi piuttosto comuni, e come tali erano esposti. Erano rappresentativi cioè di una tendenza dell’epoca, alla quale davano misure e forma. La cosa interessante, però, è come una qualche forza e volontà misteriose, regno dopo regno, generazione dopo generazione, avessero fatto sì che quegli oggetti venissero conservati con estrema cura, anziché essere scartati e gettati nella Vistula, fusi per farne dei prodotti più avanzati, o sepolti con i loro padroni.
Se ampliamo il discorso dalle armature rinascimentali agli hard disk dei giorni nostri, possiamo trovare forse un filo conduttore nei tentativi compiuti dalle società umane per preservare le proprie creazioni, che si guardi a monumenti favolosi oppure a oggetti decisamente banali. Si tratta comunque di un modo per l’Uomo di fare i conti con le tracce che ha lasciato sulla Terra, che non hanno valore solo in quanto eredità del passato, ma anche per le informazioni in esse contenute. E c’è davvero una grande differenza tra un manoscritto sarcastico lasciato incompleto da un monaco alessandrino e giunto intatto sino a noi, e la saliva presa un immigrato sceso da un barcone, per schedarlo?
È partendo dall’umanissima e lontanissima ossessione per le informazioni, dal modo in cui esse sono gestite e tramandate, immagazzinate e mercificate, che nasce Datacrazia, corposo volume edito da D Editore e curato da Daniele Gambetta per la collana Eschaton. Il titolo del libro, in realtà rimanda alla posizione egemonica di entità decisamente contemporanee, come le multinazionali tecnologiche o le dittature populiste capaci di maneggiare frotte di hacker meglio dei missili nucleari. Tuttavia, le domande che si pongono gli autori dell’antologia sono senza tempo: che succede quando una traccia umana viene salvata dall’oblio senza il permesso degli uomini? Quali sono le conseguenze politiche, economiche e sociali della persistenza della memoria? La sensazione, leggendo Datacrazia, è che questo nuovo regime dove dimenticare è vietato faccia davvero paura, ma che non tutto sia perduto.
Ci pensa Gambetta – che di mestiere fa il matematico – a spiegarci nell’introduzione che il potere dei dati è da sempre ambiguo: in cambio di un maggiore controllo sulla realtà ci si denuda di fronte a un potere più grande, rinunciando alla nozione di ineffabile, tipica delle società magiche. Storia antica, questa, rintracciabile ad esempio nella nuova numerazione delle città francesi all’epoca di Napoleone, e nella crescente standardizzazione della burocrazia che ne seguì per meglio servire la popolazione di assistenza sanitaria, copertura postale e (perché no) anche di una fiscalità efficiente e di un sistema di coscrizione agli eserciti sempre più pervasivo. Il libro però teorizza che con le nuove tecnologie, e soprattutto con il cosiddetto capitalismo “della piattaforma” (Uber, Airbnb, in parte anche Facebook e Amazon) l’attività di estrarre dati dall’esperienza umana è diventata così centrale, così totalizzante che rischia di influenzare qualsiasi aspetto della nostra società. Se Marx diceva che la lotta di classe è il motore della Storia, la lotta per l’oblio potrebbe essere il motore del futuro.
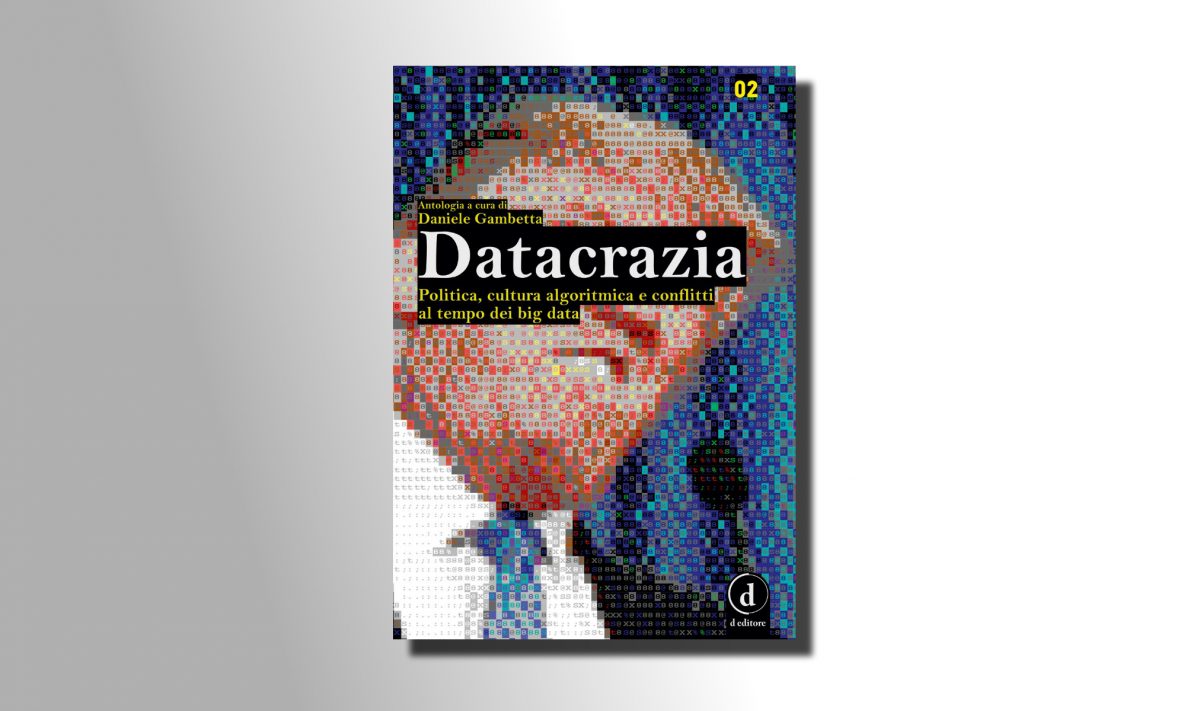
Come in un quadro di Bosch ambientato nella Silicon Valley, in Datacrazia è illustrato uno scenario in cui il potere delle aziende di trarre profitto dalle informazioni è senza freni. Sfruttando il suo miliardo e mezzo di utenti attivi, Facebook riesce a ritagliare ciascuna inserzione pubblicitaria su misura di ciascun profilo socio-comportamentale, fatturando centinaia di milioni di dollari al giorno. Si parlerà spesso di Big Data, ovvero dell’insieme di tecnologie capaci di unire i punti dello scibile per scoprire legami e genealogie, e fare previsioni: si va dai siti che visitiamo e i prodotti che compriamo, che vengono memorizzati e utilizzati dalle macchine per suggerirci quali negozi visitare, in quali ristoranti andare, e persino quali partner scegliere per costruire una famiglia. Ma sono solo quisquilie: nei prossimi anni potremmo ritrovarci con l’implementazione del “pre-cog” di cui parlava Philip Dick (in Minority Report) in tutti i livelli del vivere civile, con computer in grado di anticipare crimini e tendenze sociopatiche grazie a milioni di statistiche incrociate.
Va da sé che la pervasività del “datismo” (come lo ha battezzato il celebrato saggista Yuval Noah Harari, autore del bestseller internazionale Homo Deus) ha notevoli implicazioni positive, che sono poi quelle che ci impediscono di dismetterlo: l’interazione tra immensi database comportamentali potrebbe favorire (e in parte già lo sta facendo) la ricerca scientifica in campo medico, e prevenire il reiterarsi di atteggiamenti nocivi per la salute; l’ipotesi di una vocina che dal nostro cellulare ci assista in un una serie di scelte cruciali e meno cruciali della nostra esistenza, effettivamente, potrebbe costituire un notevole risparmio di tempo e di energie. Il problema è che gli algoritmi – altra parola chiave della nostra epoca – non sono mai neutrali, ma si basano su criteri di valutazione pre-impostati, la cui natura dipende a sua volta dalle teorie a cui si sono abbeverati i loro creatori: dell’economia comportamentale al paternalismo libertario, dal neuromarketing alle varie branche della psicologia cognitiva e delle neuroscienze. Scava scava, le macchine sono pur sempre il frutto di un preciso contesto storico, culturale e politico.
I governi, a dire il vero, non sembrano più discreti dei privati. In Cina, i dati raccolti su ogni cittadino potrebbero presto essere usati dalle istituzioni per farsi un’idea della sua affidabilità, magari poco prima di un colloquio di lavoro o di un possibile incarico politico. A New York, hanno fatto scalpore delle app che usavano i dati aggregati degli utenti per cartografare i quartieri più a rischio; ma già negli anni ’90 ci aveva pensato il sindaco Rudolph Giuliani, uno sceriffo per definizione, ad affidarsi ad un controverso sistema informatico per misurare l’efficacia dell’azione poliziesca (il CompStat). Il vero pericolo, forse, non è quello di morire a causa degli errori delle macchine, ma per la noia: a forza di affidarci agli algoritmi, quali saranno le forze capaci di prevedere e di gestire l’azzardo?

Nonostante le premesse, i saggi contenuti nel libro non ci condannano alla distopia, ma a una maggiore responsabilizzazione. Prevale, a dirla tutta, un certo ottimismo: l’inquietante social credit cinese per ora rimane confuso, o quantomeno in fase di studio; chi si occupa di ricerca accademica si fa avanti come argine all’arroganza del Big Data; chi lavora con la musica e giornalismo sembra cogliere le straordinarie opportunità dalla tecnologia, senza però scadere in un’esaltazione acritica dell’esistente. Più in generale, piuttosto che descrivere questa controversa e apolide società degli utenti come un amalgama irrimediabilmente passiva, gli autori disegnano utopie di condivisione, autonomia e accresciuta consapevolezza. Sembra chiaro, insomma, che qualsiasi questione deontologica al tempo dei Big Data debba fare i conti con la politica e con l’etica individuale, ponendosi nel mezzo tra un neopositivismo infantile (“l’Unione Europea lasci in pace Google”!) e un primitivismo cupo (“nazionalizziamo tutto, e trasformiamo il capitalismo di piattaforma in un capitalismo di Stato!”). La quadratura del cerchio al tempo del tecnopopulismo imperante: se non ora, quando?
Mentre i Millennial con l’hobby per la scrittura progettano utopie pirata, i ventenni occidentali si ritrovano con l’essere la prima generazione il cui intero vissuto sarà tracciabile e misurabile per i secoli a venire: la fine della dimenticanza è, necessariamente, anche la fine dell’invisibilità. Che lo scontro di domani debba combattersi su due fronti? Quello interno, individuale, nel disciplinamento di un sé senza più zone d’ombra, e quello interno, collettivo, tra chi lotterà per riconquistare l’oblio e chi cederà ogni segreto per vivere più a lungo? Zuckerberg starà, con tutta probabilità, a guardare: la rete è un fiume che non ci permette di seppellire i nostri cadaveri.
Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .
Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .




