Confessioni sui social di un marketer disilluso
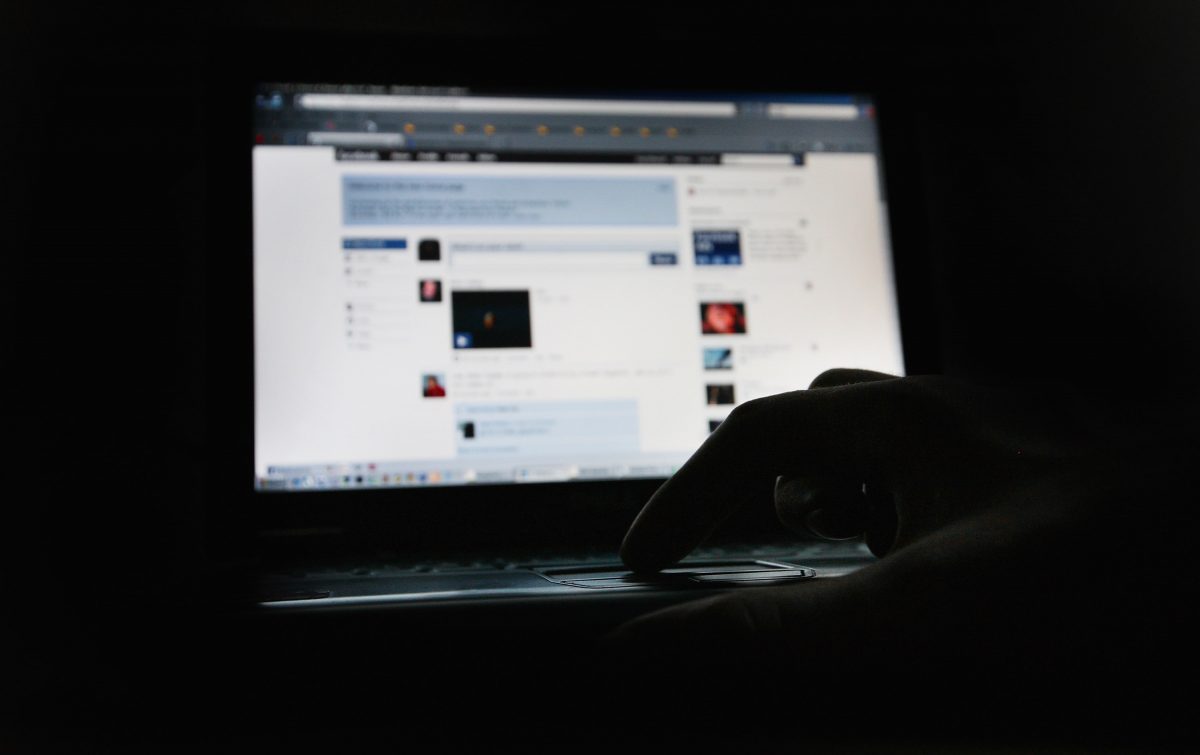
SUITEAI
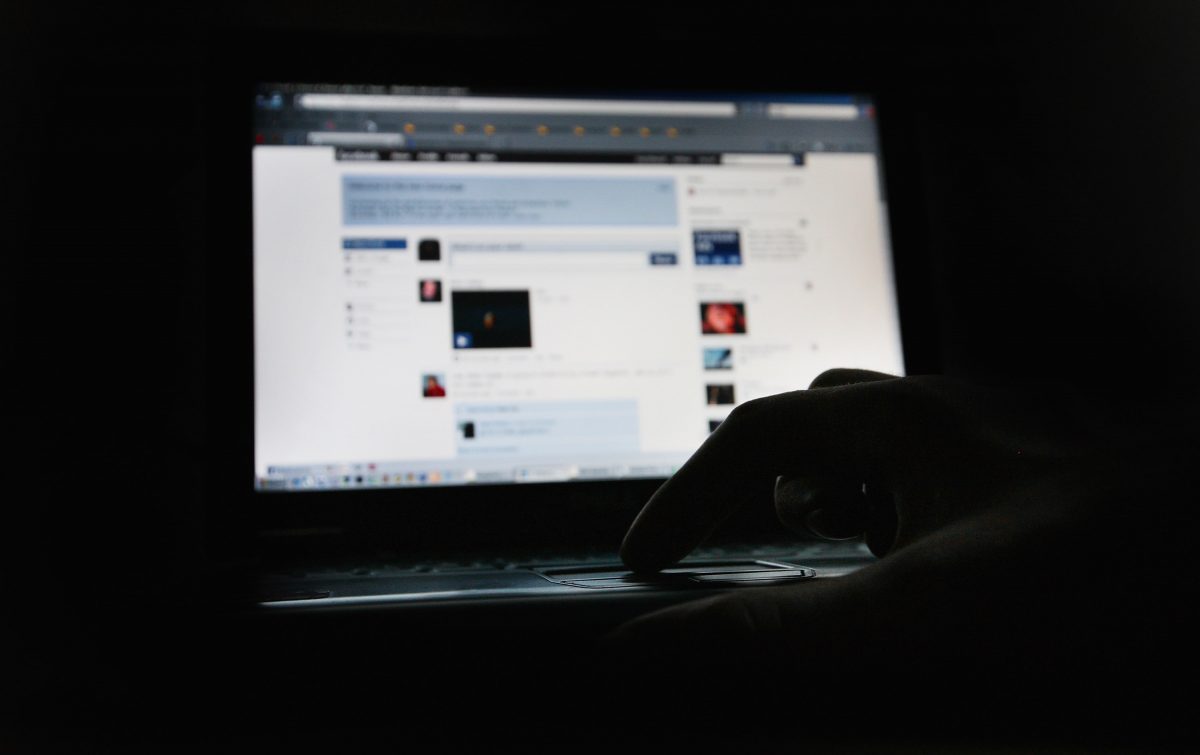
Facciamo un veloce passo indietro, a qualche anno fa, un rewind all’inizio della storia per capire da dove nasce il problema e – forse – la soluzione. Molti marketer di estrazione digitale della prima ora si ritroveranno (come me) nell’idealismo della Rete del periodo romantico (quello in cui uscivano libri che portavano titoli come Join the conversation, Wikinomics, Groundswell – «il maremoto» – eccetera). La folla connessa era vista come una risorsa (“l’intelligenza collettiva”, si diceva), e la profezia del Cluetrain Manifesto (il manifesto del nuovo mercato digitale pubblicato nel 1999, secondo cui people have the power) incombeva minacciosa sui futuri delle aziende che non avessero aperto una”relazione” alla pari coi loro clienti. Tutto doveva cambiare, nel marketing.
La community (meglio se costruita internamente al sito aziendale, dicevano i big vendor, così era più fatturabile) doveva essere il perno delle attività. Le aziende poi dovevano “diventare publisher”, perché content is king. Ma ancora prima, dovevano aprire un blog. Poi venne il momento del customer care via Twitter: un numero impressionante di eventi, case study, libri che citavano invariabilmente aneddoti di persone che volevano interagire con le aziende sui social media. Era il web 2.0 che avanzava.
Poi vennero i social, e la conseguente privatizzazione della conversazione: le aziende spostarono l’attenzione dai morenti blog aziendali e dalle languenti community alle pagine Facebook, in cui era più facile entrare in contatto con il consumatore connesso. Fu bellissimo illudersi di avere dei fan, anche se il loro valore era semplicemente quello di un opt-in intermediato, e quindi minore, per dire, di una iscrizione a una newsletter. Le aziende interpretarono la definizione di “fan” in senso stretto. Con successiva, inevitabile disillusione.
Pochissimo di tutto ciò ha scaricato davvero qualcosa a terra, facendo i conti ad anni di distanza. Solo pochissimi esempi hanno avuto un impatto duraturo sul business. Ma i casi di successo al tempo furono spacciati per best practice applicabili universalmente, anche per riempire una letteratura di settore straripante: in realtà erano belle eccezioni, in cui il brand-tipo era particolarmente “social-fotogenico” e in cui la relazione si basava su community fisiche preesistenti. Tra gli altri, alcuni esempi possono essere il primo blog Ducati – che portava idee e coinvolgimento – il forum di assistenza della prima Tre – in cui super-utenti aiutavano utenti “normali” – e il primo Mulino Che Vorrei, in cui gli appassionati di biscotti suggerivano nuovi collezionabili del Pan di Stelle.
Le conversazioni delle community proprietarie si sono presto inaridite, e solo una su mille è risultata (Kpi alla mano) davvero utile al business, anche indirettamente, considerando i risparmi di advertising e l’aumento della fedeltà, le idee ricevute e via discorrendo. In tutti gli altri casi sono stati i venditori di setacci – e non i cercatori d’oro – a guadagnare: agenzie social e fornitori di piattaforme milionarie, su tutti. E molti manager hanno approfittato, a danno della loro azienda, della sindrome da “cosa digitale nuova luccicante e disruptive” per farsi un curriculum da dirigente innovativo. Un concorso di colpa collettivo, dunque.
Il contenuto sarà anche re, si diceva, ma il re è nudo: il branded content (salvo poche eccezioni in cui è intimamente connesso con il brand purpose, una vocazione sociale genuina – penso a Patagonia, per esempio) è affogato in un mare di contenuti in cui nemmeno i publisher professionisti sembrano davvero aver capito come galleggiare. L’offerta di contenuti (mediocri) ha da tempo superato la domanda. E i contenuti aziendali — negli ambienti sociali — sono svantaggiati per engagement, flessibilità e costo, rispetto al post che l’essere umano medio (“come siete belli!”, “mi sposo!”, “auguri”) produce naturalmente.
Pensavamo, noi marketer, che fosse Twitter a rendere migliore il rapporto con il cliente: e invece le persone volevano semplicemente interagire con il post vendita nel modo più veloce, efficiente ed efficace possibile. Che, guarda caso, nell’epoca dei muri di gomma telefonici inespugnabili, si tramutava in una caccia alla membrana più porosa, per fare presto e saltare la fila. Non era voglia di relazione, era necessità di fare prima. Avessimo messo più gente a rispondere al telefono, nessuno ci avrebbe contattato via Twitter.
Il dramma della presenza aziendale su Facebook, a sua volta, coincide con il crollo del reach organico (dovuto a maggiori contenuti e alla concorrenza dei contenuti personali). La verità è che ci sono pochissimi brand che le persone desiderano davvero nel loro feed, nello spazio riservato agli “amici”. I marchi che confinano con l’intrattenimento hanno qualche vantaggio, ma finisce lì. Non è Facebook a essere cattivo: è la gente che non ci dà ascolto.

Nel periodo cosiddetto romantico la gente ha acquisito un potere enorme, e le aziende ora non sanno come monitorarlo e calcolarlo, perché sfugge progressivamente ai radar (compresi quelli digitali). Il social media monitoring ci mostra solo quello che noi stessi abbiamo pagato per dire (le marchette content production degli influencer) e ben poco altro, mentre la verità si trova in luoghi privati o nelle recensioni di Amazon, Booking, TripAdvisor, negli App Store e altri posti più neutrali, come testimonia l’esplosione di gruppi Facebook per qualsiasi interesse, prodotto e servizio. Il potere di queste conversazioni private (del resto, verrebbe da dire, una conversazione è privata o non è) lo vediamo all’opera ogni giorno: app che nascono e raggiungono il n.1 degli store in settimane; pagine di un sito con url lunghissime misteriosamente raggiunte direttamente dal 40% dei visitatori grazie agli scambi via Whatsapp. Tutto questo significa fatturati che fluttuano, crescono e calano indipendentemente dai soldi spesi in advertising. Amazon, le sue recensioni e il messaging sotterraneo tra persone possono farti decollare – o affossarti.
Molte profezie romantiche non si sono realizzate: la folla — salvo pochissimi casi — non ha arricchito la conoscenza e i processi delle aziende. La maggior parte delle persone vuole comprare prodotti fatti da chi se ne intende, non fare crowdsourcing per le aziende. E anche chi è disposto a farlo, statisticamente non è esattamente un genio. I flussi sotto i mulini che vorrei e i loro epigoni si sono progressivamente prosciugati.
D’altra parte, le aziende non sembrano in buona sostanza aver poi sofferto troppo della mancanza di “conversazione”: hanno continuato a vendere semplicemente prodotti facendo pubblicità (magari diversa, più “umana”). Le persone hanno continuato a scegliere — in modo molto più informato — il prodotto con un rapporto qualità/prezzo sufficiente. Cosa dobbiamo farci, ora, con tutti quei canali social? Come dobbiamo gestire il ciclo di vita di queste piattaforme (ieri il blog, oggi Facebook, domani Instagram, dopodomani chissà)? Dobbiamo chiuderli come ha fatto Wheterspoon in Gran Bretagna, e poi dire “visto? Non succede niente”? O tenerli in freezer e sperare che nessuno se ne accorga? Probabilmente succederà davvero: nessuno chiederà mai a un’azienda perché non posta più.
La risposta, in breve, è che non c’è una risposta, almeno non una univoca. Perché ogni caso è unico. Chi pensa che uno strumento, una tattica, una strategia, un social media, un case, un’idea, un aneddoto si possa applicare a qualsiasi azienda e settore, non ha capito niente di business. Non ci sono pietre filosofali, sia digitali che no.
Questa storia ventennale riserva grandi insegnamenti per il management aziendale e il frizzante e un po’ vacuo mondo del digitale. Il marketing farebbe meglio a tornare ai vecchi insegnamenti, cioè valutare il ritorno con metriche tradizionali: migliore conoscenza del cliente, miglioramento della brand awareness, più brand value e reputation, più soddisfazione del cliente, minori costi di sviluppo, innovazione e product design, una più lunga e prospera lifetime value del cliente, eccetera. Possibilmente in un arco di tempo medio-lungo, ricordandosi che spesso la causa e l’effetto sono facili da confondere: vendo di più perché sono di successo su Facebook, o viceversa? Dobbiamo dividere una volta per tutte gli obiettivi dagli oggetti, luccicanti o meno che siano. Anche perché gli stessi oggetti ormai, associati ad audience diverse, assumono obiettivi differenti nel marketing plan. Se parlo su Facebook ai miei clienti, Facebook diventa uno strumento di loyalty, ovvero dovrebbe fidelizzare. Se parlo agli sconosciuti targetizzati, dovrebbe insinuargli il dubbio che abbiamo qualcosa di interessante per loro (può accadere, a volte): in questo modo interpreta il ruolo della tv. Non esiste il social media marketing, come nessuno ha mai parlato di “television marketing”, diceva giustamente Samuel Scott in “How Google Analytics ruined marketing”, un articolo pubblicato su TechCrunch.
Dobbiamo rilassarci e pensare che le persone che ci amano (una minoranza, sempre) ci seguiranno ovunque, su qualsiasi piattaforma, passata, presente e futura. Al contrario, quelle che ci hanno messo un like una volta per sbaglio non sono una grande (né significativa) perdita. Mettiamoci in testa che nessun ambiente social dà gli stessi vantaggi a tutti: la vostra azienda non sarà Ceres (posto che Ceres venda più birra grazie ai suoi social, come gli si augura). Anche se i vostri concorrenti sbarcano sull’ultimo social network più cool, decidete se volete apparire come il manager che segue a ruota o come qualcos’altro. Per riavvicinarsi ai clienti e sfruttare il loro know-how per lo sviluppo basta uno strumento fuori moda: la community. (pensate ai gruppi più o meno ufficiali del Bimby, che creano ricette e dà motivo d’essere allo stesso prodotto).
È facile, dopotutto: dobbiamo calcolare costi e vantaggi nei mezzi che oggi abbiamo a disposizione per contattare – nel modo meno intrusivo possibile – le persone. Per capire com’è l’esperienza percepita dai clienti che hanno comprato il mio prodotto devo pagare Facebook? Pazienza, pagavo le società di ricerca anche prima. Devo sussidiare Facebook per contattare personaggi indifferenti e sconosciuti che suppongo possano concedermi cinque secondi di attenzione? Beh, in fin dei conti lo facevo anche prima con la tv. Niente di nuovo sotto il sole.
Mi sembra di identificare un chiaro corollario finale: non esiste una social media strategy, ma solo una tattica di canale: come decidere cosa far recitare al telemarketing. Cosa scrivere, a chi, con che tono, con quale foto inutile, e così via. Sono tutte tattiche, non strategie. Esiste, là fuori, solo la strategia aziendale. Puntare a creare affluenza di persone dai cerchi periferici dell’affezione – popolati di sconosciuti – a quelli centrali dei veri fan, ovunque siano e qualunque sia la modalità e l’idea di base. Creare un’olistica macchina digitale (e no) che lavori sui diversi canali, in modo agnostico rispetto a mode e hype. Il resto è social inutilità, che serve a farci perdere tempo su notizie ricopiate dai blog tecnologici americani che ricopiano i comunicati stampa dei vendor tecnologici, i quali a loro volta devono venderci l’ennesima spada magica.
Vuoi ricevere le notizie di Forbes direttamente nel tuo Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!
