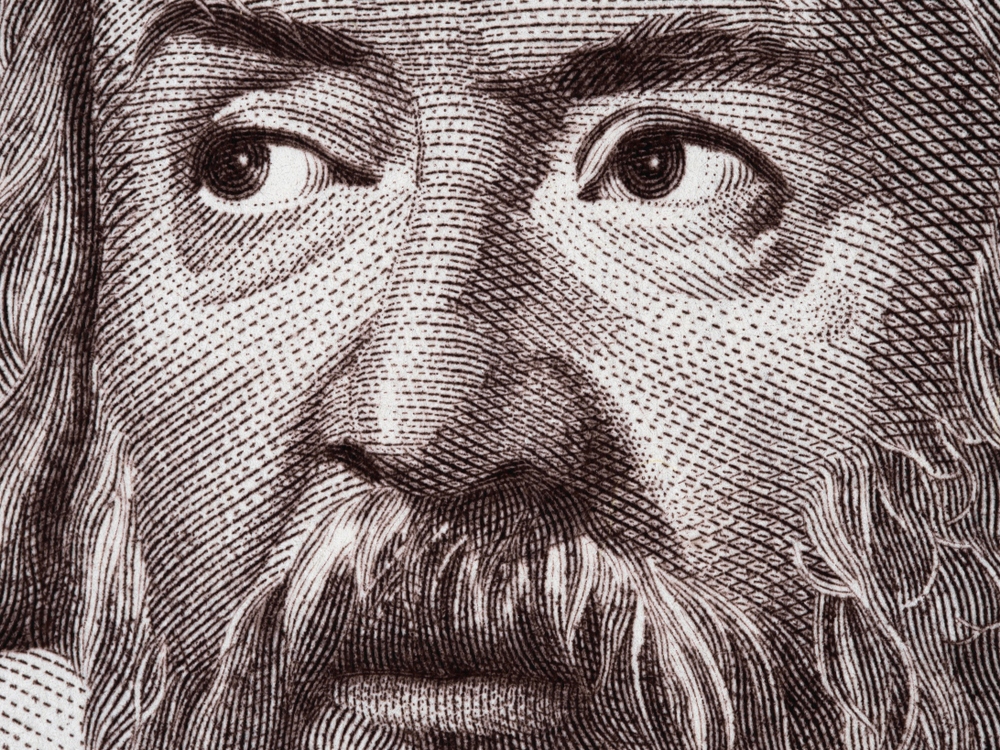Uno dei risvolti più interessanti di questa fase storica è il mescolamento nel dibattito italiano di temi vecchi e nuovi, di firme giovani alla moda e meno giovani riemerse dall’oblio. Assistiamo così a uno sfondamento di frontiere ideologiche un tempo invalicabili, e l’incontro di personalità e idee che, fino a pochi anni fa, nessuno avrebbe pensato di vedere a braccetto. Ad esempio, sul Corriere della Sera è possibile trovare ormai da mesi, fianco a fianco, editoriali allarmati per la rabbia montante contro il cosmopolitismo e il parlamentarismo, e altri invece a favore della riscoperta dell’omogeneità culturale e dello sciovinismo economico. La cosa divertente è che capita di vedere opinionisti un tempo uniti sul fronte liberal conservatore, oggi spartiti tra chi si iscrive a quello riformista-progressista e altri che possiamo definire sovranisti di sinistra.
Se i primi tentano disperatamente di mantenere in piedi il vecchio ordine liberale e di aderenza alla Unione Europea e alla Nato, il discorso dei secondi è che ci sono caratteri immutabili nella nostra cultura e che l’adesione agli organismi sovranazionali ci avrebbero privato di capacità decisionale in materia economica e, quel che è peggio, annacquato l’identità patria. Il problema degli uni e degli altri è che tendono a selezionare soltanto le informazioni a suffragio delle loro tesi, cancellando spesso e volentieri decenni di storia. A partire dagli scherzetti finanziari e le numerose bolle inflattive che avevamo subito, da italiani, con la nostra liretta.
È significativo che proprio sul Corriere della Sera, il 27 febbraio 1976, sia comparso un articolo dal titolo significativo: I limiti dei prestiti. Lo riporta il giornalista Mario Seminerio sul suo blog: in quell’articolo si ritrova una specie di trama neorealista, in cui l’Italia, da anni nei guai con la sua bilancia dei pagamenti, andava in giro per il mondo ad elemosinare prestiti praticamente da chiunque. Certo, avevamo le nostre ragioni: c’era stata la crisi petrolifera, la disoccupazione era crescente e si partiva da livelli di miseria e insicurezza economica infinitamente superiori a quelli di oggi; c’erano ancora migliaia di chilometri di autostrade da costruire, edificare non era complicato come adesso, le famiglie del sud facevano il doppio dei figli con la metà dei servizi sociali di oggi. Eravamo un paese ancora abbastanza giovane e in crescita, ma non certo la planetaria con una valuta che faceva tremare il mondo:
“[…] Eventuali attacchi speculativi nei confronti della nostra moneta sono sempre ipotizzabili sia in questo contesto di generale disordine monetario sia tenendo conto della obiettiva fragilità dell’economia italiana.
[…] Un miliardo di dollari dovrebbe venire dal prestito CEE entro la prima metà di marzo.
[…] alla Bundesbank potremmo chiedere la restituzione di 500 milioni di dollari che avevamo rimborsato anticipatamente sul prestito di 2 miliardi di dollari dell’anno scorso.
[…] Calcolando pure perciò un totale di riserve di 3 miliardi di dollari si può già prevedere fin d’ora che più di un terzo verrà speso quest’anno solo per il rimborso degli interessi e di parte del capitale dei debiti contratti in precedenza che attualmente ammontano a 14 miliardi di dollari circa”.
In poche parole l’Italia, nonostante i prestiti precedenti, era priva di valuta e non poteva permettersi le importazioni di cui aveva bisogno: neppure stampando la moneta in casa. Così, il governo italiano si presentò col cappello in mano a chiedere soldi a chiunque avesse quanto meno le nostre simpatie: la CEE, il FMI, gli Stati Uniti, la Germania, la Francia, la Gran Bretagna. Ma come faceva uno stato con valuta propria, così laborioso, così creativo, così pieno di “eccellenze”, a non affermarsi nel mercato, a non vedere un boom dell’export, e soffriva invece di continue crisi nella sua bilancia dei pagamenti?
Ora, stando alla metafora filmica, pensate un fermo immagine sul volto di Marco Polo della vecchia 1000 lire: “Sì, questo sono io. Vi starete chiedendo come sia finito qui”. Flashback al 1971. Allora, l’Italia fa parte del regime di Bretton Woods: mantiene un tasso di cambio fisso – ma aggiustabile – col dollaro americano, e questo a sua volta ha un valore in oro. Nel 1963-1964 la lira è vittima di un grosso attacco speculativo: si trova in pieno boom economico, i sindacati vanno forte, i salari in aumento, e con essi la produttività. Ma cresce anche l’inflazione: e così i mercati iniziano a dubitare della sostenibilità del nostro debito e scommettono sulla svalutazione della nostra moneta.
Ma non ci riescono. Per due motivi: la Banca d’Italia ha già iniziato ad attuare politiche fiscali restrittive, e soprattutto perché il governatore Guido Carli è andato segretamente a Washington, per farsi emettere prestiti per 800 milioni di dollari, insieme a quelli già ottenuti dalla Germania, dall’Inghilterra e dall’Fmi. In poco tempo, questi accordi diplomatici salvano la lira e la nostra economia, che può proseguire per un altro decennio di crescita sostenuta, in un clima macroeconomico ispirato alle idee keynesiane che rassicura le imprese: gli sbocchi per la domanda dei loro prodotti sarebbero stati garantiti, ove necessario, dagli interventi pubblici. La cosa interessante, ha spiegato l’economista Paolo Rodano “è che di questi interventi non c’è stato bisogno perché la rassicurazione pubblica spingeva le imprese a investire e a far crescere la domanda aggregata”. Ma nel 1971 tutto cambia: alla fine del cambio fisso voluta da Nixon si somma l’esplosione del prezzo delle materie prime, con il conseguente boom dell’inflazione. Il fenomeno è mondiale, ma da noi, dove l’economia è dominata dalle piccole imprese esportatrici, gli effetti sono devastanti. Finisce, insomma, la golden age.
Ora un’altra scena, stavolta un flash forward: è il 1992, la fine di Bretton Woods ha avviato da almeno un quindicennio una progressiva liberalizzazione dei mercati, nonché una finanziarizzazione dell’economia sempre più pervasiva. Già alla fine dei Settanta i vantaggi della continua rincorsa tra cambio, prezzi e costi si erano esauriti, e si era deciso di rientrare in un sistema di cambi fissi ma aggiustabili (il Serpente Monetario Europeo) e di separare il Tesoro dalla Banca d’Italia (che in precedenza era obbligata a finanziare i disavanzi e i debiti). Nell’Italia sovrana c’è però una nuova crisi dei pagamenti e un nuovo tentativo di speculazione (in cui fa la sua parte, lo ricorderete, anche George Soros). Non finirà bene come trent’anni prima. Il salvataggio da parte dei partner europei questa volta non ci fu, perché i tedeschi erano impegnati nella salatissima unificazione e il conto fu fatto pagare interamente ai paesi più poveri. La lira dunque esce insieme alla sterlina inglese dallo Sme, si svaluta, ma non si registrerà alcuna ripresa economica, né sotto forma di crescita di salari né delle esportazioni. Iniziano le manovre sanguinose di Giuliano Amato. Col 1992 si certifica, effettivamente, l’inizio di una stagnazione che durerà fino ad oggi.
La grande recessione del 2008, e la ripresa a passo di lumaca successiva che ne seguirà, rimescolano il consenso pubblico post-1992 sulla gestione della moneta e della spesa, ritirando fuori, esclusivamente tramite il discorso politico, teorie screditate fino al midollo, o comunque non del tutto convincenti. Non solo in Italia: la Modern Monetary Theory (Mmt), che qualcuno ironicamente chiama keystroke economics, è tornata in auge anche Oltreoceano, fungendo da religione perfetta per chiunque voglia evitare di parlare di conflitti di classe, allocazione generazionale delle risorse, capacità produttiva e altre cose complicate. Ovvio che l’idea di stampare moneta come se non ci fosse un domani per abbassare il debito pubblico affascini persino Trump (che pare l’abbia suggerita al suo consigliere economico, Gary Cohn) o per chiunque spacci come passeggiate la deglobalizzazione e l’autarchia produttiva. Preoccupa, piuttosto, che ripetano certe formule magiche anche i consulenti della nuova star socialista Alexandra Ocasio-Cortez, la quale poi, quando le chiedono come finanziare la spesa sanitaria, fa una brutta figura.
Cinquant’anni di vicissitudini italiane dovrebbero insegnarci che il nostro paese, dipendente com’è dalle relazioni diplomatiche internazionali, dalle materie prime e dalla globalizzazione, era stato molto meno “sovrano” e competitivo di quanto oggi si tenda a credere. Già nel 1976 iniziarono a piombare sulla Dc – come un governo Berlusconi qualsiasi – le ricette del Fondo Monetario Internazionale in tutta la loro durezza liberista: stretta monetaria per attrarre capitali con tassi nominali e reali in aumento rispetto al resto del mondo, stretta fiscale per sopprimere domanda interna ed importazioni. Eravamo, già allora, un sorvegliato speciale.
È vero che i democristiani si ribellarono a quei precetti, ma lo fecero per preservare la pace sociale in un paese sull’orlo di una guerra civile, e soprattutto per gettare le basi di una diarchia col Pci basata su clientelismi e prebende. Il culmine si raggiungerà negli Ottanta, con democristiani e socialisti che raddoppiarono il debito fino a renderlo un macigno, che avrebbe spinto la Seconda Repubblica a privatizzare in modo frettoloso e confuso. Entrare nell’euro in quelle condizioni, probabilmente, fu un errore, ma questo non vuol dire dimenticare cosa siamo stati, come paese, e come siamo arrivati all’oggi, dove si paventa un’uscita disordinata e unilaterale.
Gli stregoni dell’economia hanno successo in tempi di crisi perché hanno soluzioni semplici a problemi complessi. L’idea che la Bce e i governi nazionali oramai senza sovranità debbano sottostare a leggi globali finanziarie che assoggettano i popoli sempre più nella indigenza, sembra quantomeno superficiale e fantasiosa. La convinzione che la salute delle democrazia moderne dipenda soprattutto dalla stampa di moneta, che questo sia l’unico modo per finanziare le spese necessarie a sollevare i poveri dalla indigenza, depoliticizza del tutto il fattore culturale, quello educativo, quello sistemico, strutturale: sembra più una forma di autoipnosi collettiva che il frutto di una verifica empirica.
Cedere il potere di stampare moneta comporta conseguenze serie per la qualità della democrazia, e il rischio dell’accentramento di ricchezze verso certi territori e classi rispetto ad altri. La crisi della legittimazione politica liberale e dei tecnocrati è serissima e potrà avere forse effetti emancipatori e di mobilitazione importanti. La sciagurata – altre parole non ci sono – stretta fiscale prociclica imposta dalla miopia dei tedeschi ha fatto da catalizzatore per la nostra crisi politica, riattivando la nostalgia e le lenti deformanti dell’Età dell’Oro della lira. Il problema, drammatico, è che uscire da un’area monetaria così grande è un’operazione del tutto inedita nella storia mondiale, e non potrà che avere conseguenze drammatiche se prima non si chiariscono quali potrebbero essere i benefici. Soprattutto, non sembra nemmeno lontanamente immaginabile un’uscita “da sinistra”, in senso keynesiano, perlomeno. La morale è che la sovranità è un concetto molto più ideologico che reale: prende la forma in cui te la vendono i protagonisti dell’egemonia culturale del momento: molto spesso, nasconde una forma di deresponsabilizzazione molto più forte di quella causata dagli organismi sovranazionali.
Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .
Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .