Tutti pazzi per il paywall. L'on demand salverà i giornali?
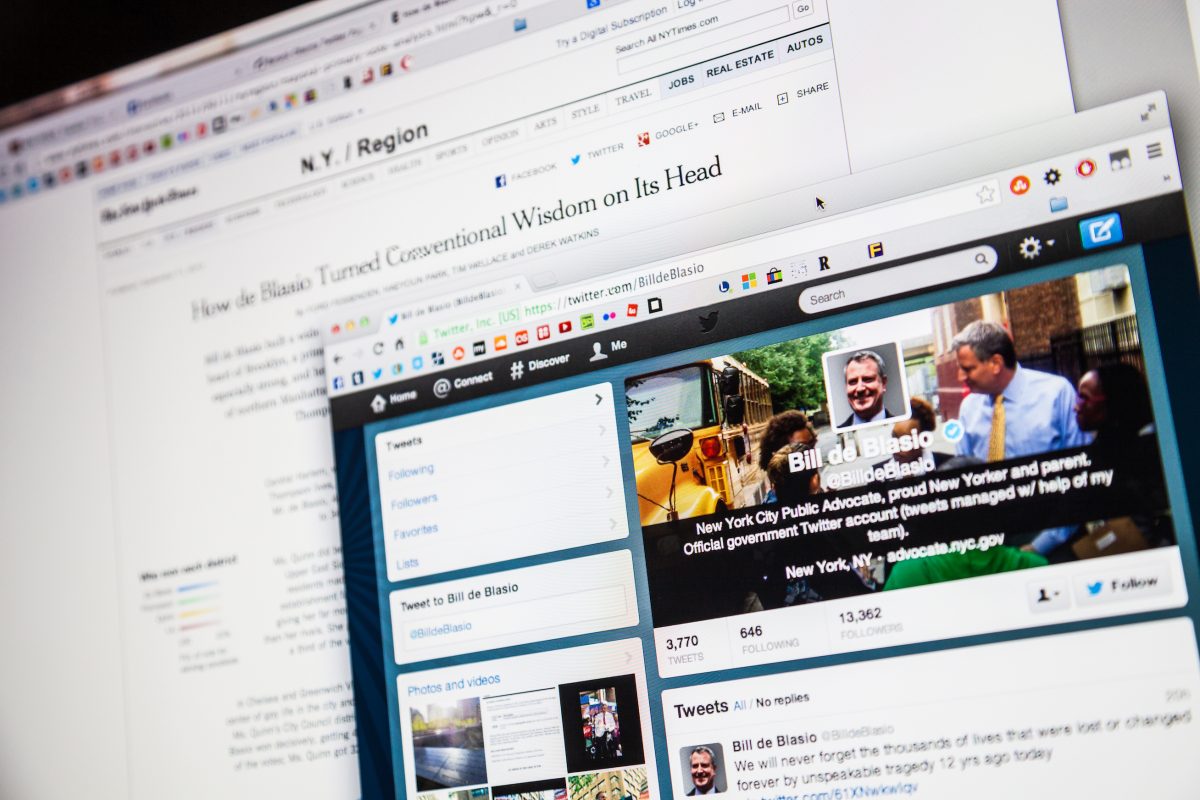
SUITEAI
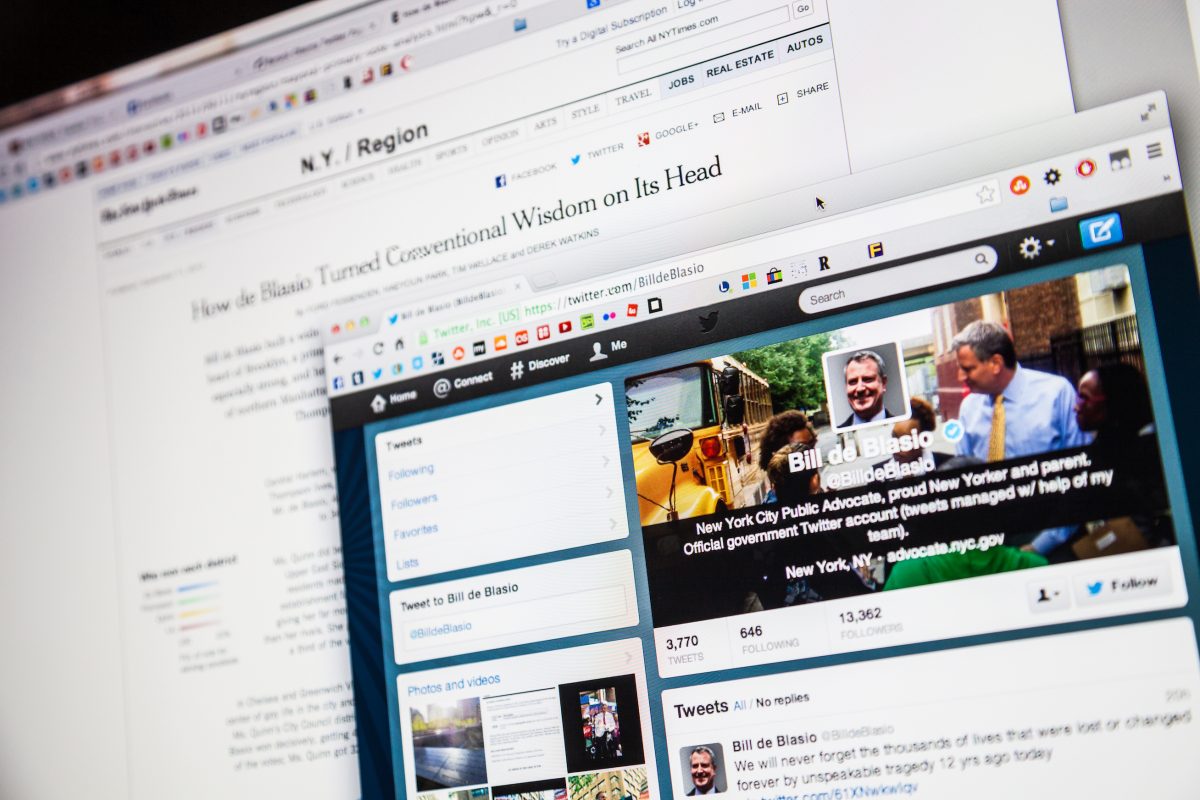
Il sistema congegnato dai giornali per sopravvivere alla crisi del cartaceo sembrerebbe funzionare, al punto da essere diventato un modello anche per chi dalla carta non c’è mai passato. Negli Stati Uniti la tendenza è chiara: Bloomberg, Vanity Fair, Wired, Business Insider e The Atlantic sono tra i siti d’informazione e approfondimento che l’anno scorso hanno lanciato il loro paywall, il sistema che limita la fruizione dei contenuti agli abbonati. Cnn, Axios e altri hanno fatto capire che servizi di questo tipo partiranno nel prossimo futuro. E istituzioni come il New York Times, il Wall Street Journal, il Washington Post e il Boston Globe hanno allargato sempre di più la fascia di contenuti online il cui accesso è consentito solo a pagamento.
Se così stanno le cose, quali sono i fattori che hanno contribuito a rendere il paywall una strategia di successo, perlomeno oltreoceano? Da un lato, c’è la crescita della pubblicità online: secondo Recode, le vendite di abbonamenti online al quotidiano newyorchese sono aumentate del 46 per cento nel 2017, arrivando a 340 milioni di dollari, mentre i ricavi delle digital ad sono aumentati del 14 per cento (238 milioni di dollari) nello stesso periodo. Un business che, secondo il sito di informazione tecnologico, “sta crescendo alla stessa velocità di Facebook e più veloce di Google”. L’obiettivo dichiarato del Times è raccogliere 800 milioni di soltanto dal digital entro il 2021. Per un confronto: i ricavi dell’azienda oggi sono di 1,55 miliardi di dollari, per il 60 per cento derivano dagli abbonamenti (cartacei e online). È la fidelizzazione, in qualsiasi sua forma, a sostenere le ambizioni giornalistiche.
D’altro canto, c’è da ringraziare il nemico pubblico numero uno della stampa liberal: l’inquilino della Casa Bianca. Come racconta un navigatissimo opinionista del Times, Jim Rutenberg, il 2017 è stato l’anno del “botto di Trump”, vale a dire un aumento considerevole sia di inchieste d’alto livello sia dell’interesse del pubblico a leggere storie riguardanti il presidente. Tutto ciò che ha a che fare con Trump cattura l’attenzione dei lettori, e quindi favorisce il consumo di prodotti di informazione (con una esternalità negativa, però: i giornalisti non sanno più stabilire le priorità nel dare certe notizie; che poi è uno degli obiettivi della strategia mediatica di Trump). Sarà anche un paradosso, ma in ogni caso l’accesso all’informazione e all’intrattenimento on demand è diventato un’abitudine di consumo radicata, in America, e sta indubbiamente aiutando diverse testate a monetizzare.
In Italia la situazione è più complicata. Tre anni fa, quando Repubblica, Corriere e Il Sole 24 Ore lanciavano timidamente i loro paywall (e i risultati degli abbonamenti online non erano certo esaltanti) Stefano Quintarelli, presidente del Comitato di indirizzo dell’Agenzia per l’Italia digital, tracciava un quadro pessimistico: “Da noi spesso il gioco può non valere la candela”, spiegava a Lettera 43. “Passando a sistemi come il paywall rischi di limitare gli utenti che oggi ti seguono perché [possono farlo] gratis, e perché sono poco sensibili alla differenza tra il giornalismo di qualità e quello popolare”. Due anni dopo, un rapporto pubblicato da Pay For News, realizzato da Associated Press e American Press Institute, rivelava che se 54 per cento degli statunitensi possedeva un abbonamento online a un quotidiano; in Italia, la percentuale scendeva al 4 per cento, ultima tra i grandi Paesi europei.
Insomma, gli utenti sono ben disposti a pagare per le notizie, se ti chiami New York Times, o sei puoi permetterti di scrivere sul frontespizio del tuo giornale “Democracy Dies in Darkness”, che la democrazia muore nelle tenebre; meno, se fai inchieste nel mare opaco (e inquinato) che è il giornalismo italiano, e se pensi di organizzare la resistenza al populismo con dei post-it in un mare di errori e imprecisioni. La chiave di tutto, come sempre, è il valore che l’utente dà al prodotto: gli americani non si preoccupano del prezzo se la qualità è alta, e i numeri dimostrano che i margini di crescita si sono rivelati notevoli. E da noi?
In Italia, procede tutto più a rilento. Secondo il Digital News Report 2016, elaborato dal Reuters Institute for the Study of Journalism dell’Università di Oxford, in Italia due anni fa si spendevano in media 28 sterline l’anno in abbonamenti online, contro le 82 sterline del Regno Unito, le 62 degli Stati Uniti e le 40 della Spagna. Secondo un altro studio, più recente, delle quasi quindici milioni di copie di periodici venduti in Italia ogni anno, solo il 3 per cento è in formato digitale. Un mercato così magro è il frutto dell’indole dei lettori italiani, o sono forse stati educati così?
Il ritardo è, purtroppo, frutto di una serie di scelte strategiche quasi suicide. Il giornalismo italiano, per decenni legato a dinastie imprenditoriali e a visioni politiche ben precise – se non quando a specifici partiti – ha dovuto destreggiarsi, negli anni ’90 e primi anni Zero, tra la distruzione del panorama ideologico di riferimento e lo scombinato (e impopolare) sistema di finanziamenti pubblici alla stampa, oggi drasticamente ridotto. È in questo periodo, ha scritto l’esperto di comunicazione e media Alessandro Gazoia, che è avvenuto il disastro:
Nei siti web dei grandi giornali, quasi tutti ad accesso gratuito, come la televisione commerciale, la tensione tra alto e basso è diventata fortissima […] si è scelto di abbassare clamorosamente la soglia di cosa è/fa notizia rispetto al cartaceo, anche per la possibilità di generare lungo tutto l’arco della giornata una quantità di immagini e brevi testi che sul giornale di carta non avrebbe mai potuto trovare posto.
Secondo Gazoia, che ha dedicato all’argomento un lungo e dettagliato saggio, dal titolo Senza filtro (Minimum Fax, 2016) quella strategia puntava ad “attirare quei lettori digitali che non comprano il Corriere in edicola e non pagherebbero per le notizie sul web ma guardano volentieri una galleria fotografica sulla modella che scende dalla macchina o il gattino che scende dall’albero. I giornali autorevoli volevano far crescere le pagine viste, parametro fondamentale nel cosiddetto modello CPM (costo per migliaia di pagine viste) di vendita della pubblicità”. La pubblicità pagata per volumi di traffico, quindi: una specie di salario a cottimo per l’informazione, costretta a cedere sempre di più ai meccanismi del clickbait piuttosto che a potenziare il proprio marchio e ad attirare i propri lettori con la qualità.

Certo, la crescente economia del paywall presenta aspetti controversi anche laddove sembra funzionare. Quelli di TechCrunch fanno notare come le sottoscrizioni online stiano diventando sempre più costose e invadenti, e molte app che prima erano gratuite ora non lo sono più. Secondo i calcoli dell’autore dell’analisi, Danny Crichton, il regime attuale di abbonamenti non è sostenibile per l’utente medio degli Stati Uniti. “È un’economia per l’1 per cento”, spiega. “Focalizzata su un segmento molto piccolo di utenti che hanno dimostrato di essere disposti a pagare per i contenuti”. Sulla newsletter Silicio, il giornalista Eugenio Cau ha fatto due conti anche in Italia ed è giunto alla conclusione che l’economia degli abbonamenti qui da noi è ancora meno sostenibile, perché i nostri salari sono mediamente più bassi.
Secondo Crichton, la colpa è del restante 99%. Vale a dire di quanti, tra i consumatori, ritengono sia normale usufruire gratis di qualsiasi servizio (tranne, magari, Netflix o Amazon Prime). Il tasso di riconversione dei lettori online in abbonati paganti – clamorosamente basso – è del resto un indicatore abbastanza fedele di questa realtà: Il Nyt ha 89 milioni di utenti unici al mese, ma soltanto 2,2 milioni di abbonati. Il Guardian ha 800mila “sostenitori” (financial supporters) ma è poca roba rispetto al record di 140 milioni di visitatori annuali raggiunto qualche tempo fa. Semplificando, lo slogan dovrebbe essere: pagare tutti per pagare meno.
I numeri, in ogni caso, ci dicono che le notizie a pagamento saranno sempre più cruciali per tamponare, almeno parzialmente, il declino del cartaceo, che sembra inevitabile. Persino il New York Times, se continua a crescere negli abbonamenti online, assiste impotente al calo delle copie vendute nel cartaceo, e dei relativi introiti pubblicitari. Secondo Felix Salmon, un massmediologo intervistato da Recode, eliminare il prodotto di carta aiuterebbe i quotidiani già affermati come il Times a far crescere gli abbonamenti online. Il paradosso, spiega, è che oggi chi si abbona online considera “le copie cartacee come prodotti accessori”, e non viceversa. In altre parole il cartaceo si sta riducendo sempre di più a bene di lusso, a consumo ostentativo.
La sfida del paywall diventa al tempo stesso economica e culturale. I siti italiani, più di altri, si ritrovano a pagare anni di approssimazione e appiattimento: gli editori nostrani per un certo periodo non si sono preoccupati perché intendevano puntare sulla carta. A questo punto, verrebbe quasi da mettere in guardia il Times sull’errore commesso da alcuni giornali di queste latitudini durante vent’anni di ossessione per Berlusconi: focalizzarsi troppo su un solo “prodotto”, su una “monocultura” può rivelarsi una scelta sciagurata nel lungo periodo.
Cosa ci riserva il futuro? Negli Stati Uniti, il dibattito in corso riguarda l’ipotesi che le aziende che fanno informazione possano includere, con gli abbonamenti online, altri servizi on demand: per esempio Spotify, che per un certo periodo era stato abbinato al servizio NYT All Access. Secondo Politico: “Ciò diventerà ancora più probabile nel momento in cui Apple lancerà i suoi pacchetti con Apple Music/Apple TV/Apple News”. In Italia, nonostante il recente restyling di Repubblica.it (che deve ancora dimostrare di aver dato i frutti sperati) e l’integrazione con il cartaceo che procede spedita, i quotidiani online sembrano ancora arrancare in un profluvio di imprecisioni, approssimazione e notizie di qualità costantemente al ribasso.
La sensazione è che in Italia i lettori non vedono i contenuti dei giornali mainstream come strumentali per il proprio lavoro; non li considerano indispensabili per la propria formazione come cittadini, ma sostanzialmente rimpiazzabili dal primo sito che passa. I “lettori forti” – quelli che hanno bisogno di notizie fresche, affidabili, senza possibilità di refuso e senza distrazioni intorno – spesso sono anche i più internazionalizzati, e si rivolgono al mercato straniero. Varrebbe forse chiedersi quante siano, nel nostro Paese, le testate che possano essere viste se non come fonti autorevoli, perlomeno come beni accostabili a quel peculiare consumo ostentativo cui si faceva riferimento sopra. Il concetto probabilmente riguarda solo Il Foglio (che pure si sta sbracciando per conquistarsi un po’ di aficionados digitali) e, tra i quotidiani di medie dimensioni, Il Fatto Quotidiano (il cui business plan per affrontare l’eventuale governo M5S-Lega meriterebbe di essere studiato alle università, in caso di successo).
Con le riviste, invece, a sentire l’editor di Einaudi Francesco Guglieri, staremmo attraversando una vera e propria “età dell’oro”, fatta di blog d’avanguardia, longread curatissimi, riviste online che finiscono con l’influenzare gli inserti culturali mainstream, lettori sempre più attenti e fedeli. Certo, c’è da scremare i progetti solidi (pochi) dalle tigri di carta (tante) e c’è da capire quanto gli affezionati lettori sarebbero disposti a spendere, in caso di entrata in scena di un “paywall di nicchia”; oppure, se la loro affezione dura finché è gratuita. Ma qui mi fermo, anche per un evidente conflitto d’interessi.



