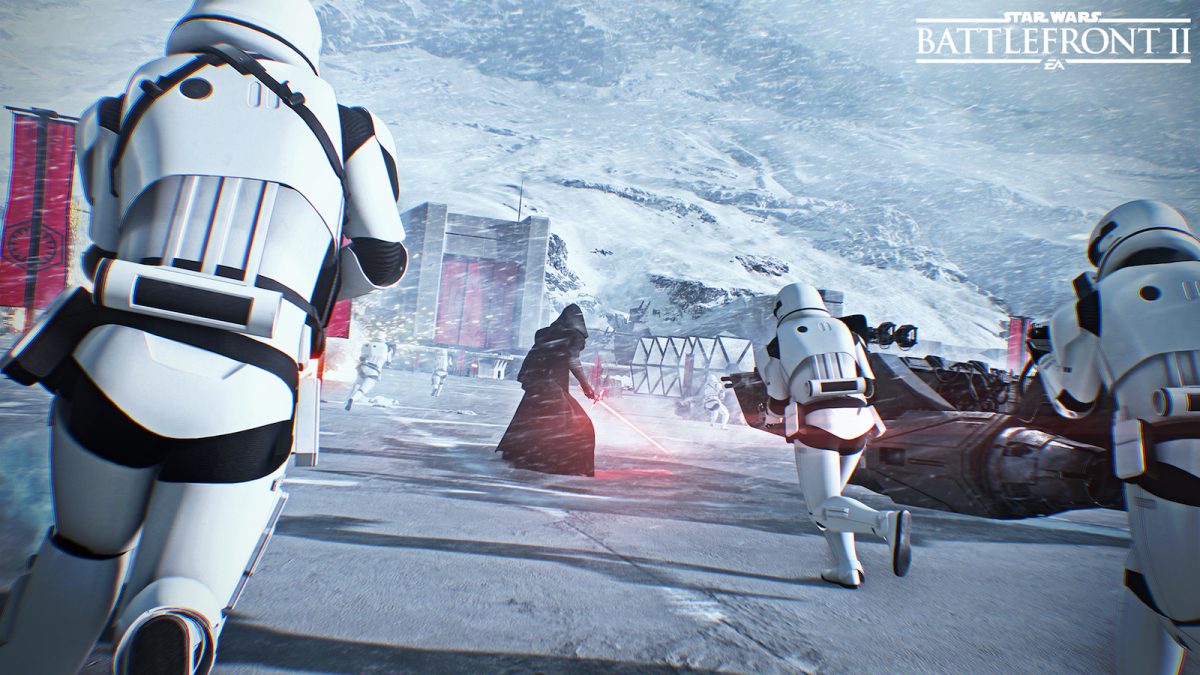
“È un casinò a tema Star Wars, cui non permetteremo di incoraggiare i nostri bambini al gioco d’azzardo”. Parole di Chris Lee, parlamentare hawaiano chiamato con il collega Sean Quinlan a esprimersi su Battlefront 2, il nuovo videogioco dedicato a Guerre stellari al centro di un ciclone iniziato ben prima che il titolo stesso venisse pubblicato dieci giorni fa.
Una tempesta, a osservarla bene, molto più estesa del caso stesso. E che per essere inquadrata in modo corretto va descritta dall’inizio, perché rischia di creare un precedente pesante nell’industria del videogioco, che con un giro d’affari di 95,6 miliardi di dollari nel 2017 (+10% anno su anno) è la più proficua dell’intrattenimento tout court (fonte: SuperData/Digital River).
Qualche settimana fa Electronic Arts, l’editore di Battlefront 2, nonché il publisher videoludico più importante al mondo, aveva fatto sapere che per sbloccare i personaggi principali del gioco, da Darth Vader all’eroina della nuova trilogia, Rey, sarebbero servite 40 ore ciascuno. Oppure spendere cifre aggiuntive al prezzo base del titolo, 60 euro.
Una pratica, quella degli acquisti in-game, ereditata dai cosiddetti free to play, quei titoli gratuiti – da Clash of Clans a Candy Crush – che capitalizzano attraverso microtransazioni successive. Con un distinguo significativo: le comunità di appassionati, ormai use a metter mano al portafoglio a partita iniziata, lo fanno volentieri solo se gli acquisti aggiuntivi non modificano gli equilibri di gioco. In caso contrario, urlano al pay to win, disdegnando videogiochi in cui una maggiore spesa corrisponde a un’accresciuta probabilità di successo.
Non a caso, alla notizia su Battlefront 2, i fan sono insorti in massa, con 675mila commenti negativi sul sito Reddit, solo il preludio di una notevole quantità di ordini disdetti. In 24 ore, il 17 novembre, le azioni di Ea si sono svalutate del 4%. Tanto da costringere gli sviluppatori del gioco, la società svedese Dice, ed Electronic Arts ad annunciare la sospensione delle microtransazioni previste, si mormora su invito diretto di Bob Iger, il direttore esecutivo di Disney, che del marchio Star Wars è proprietaria.
Nel frattempo, con il Belgio in testa e i parlamentari hawaiani in scia, si sono avviate indagini per capire se le microtransazioni in-game – soprattutto per i cosiddetti loot boxes, forzieri acquistabili che restituiscono oggetti casuali – permettano di equiparare i titoli che li sfruttano, da Battlefront 2 a Overwatch, a giochi d’azzardo. Con le ovvie conseguenze giuridiche (ed economiche) dell’eventualità. A indagini ancora in corso, il ministro della Giustizia belga, Koen Geens, ha auspicato che qualora venissero presi provvedimenti, questi si estendessero a tutta l’Europa.
Come anticipato, il caso è ben più complesso delle guerre stellari che l’hanno innescato. Da una parte perché rimane da capire se si sia di fronte a un’avanguardia del diritto dei consumatori oppure a una nuova declinazione digitale della gogna pubblica, soprattutto a fronte del fatto che nessuno dei giocatori che si sono espressi sulla questione poteva conoscerne per intero l’oggetto: il gioco non era ancora stato pubblicato.
Dall’altra perché, sebbene in maniera meno spudorata di Battlefront 2, espansioni a pagamento, microtransazioni e loot boxes sono sempre più diffusi nei videogame cosiddetti “tripla A”, campioni di incassi come Fifa 18, Nba 2k18, L’ombra di Mordor, Forza Motorsport 7 e Need for Speed Payback.

Alla faccia delle lamentele, la loro diffusione ha ragioni semplici: come dichiarato in un report per gli azionisti da Ubisoft, il terzo publisher più importante del settore, nei primi due quadrimestri del 2017 “le spese ricorrenti dei giocatori” sono aumentate dell’83% anno su anno. Acquisti in-game, abbonamenti, contenuti aggiuntivi hanno fatto incassare all’azienda 175 milioni di dollari. Tornando a Electronic Arts, la sola vendita dei pacchetti “Ultimate Team” di Fifa 17, sorta di bustine di figurine con contenuti casuali, da settembre 2016 ha spostato 411 milioni di dollari.
Oltre a confermare questo dato, l’analisi di mercato di SuperData e Digital Dilivery ribadisce il concetto: nel 2016, un quarto dei ricavi digitali dei giochi per pc è arrivato da microtransazioni e vendita di contenuti aggiuntivi (triplicate anno su anno). In sintesi, quand’anche sporco, il gioco vale la candela.
Non è un caso che oggi, dopo il tramonto dei “videogame come esperienza” della generazione precedente, il paradigma produttivo imperante nell’industry siano i cosiddetti games as service, ecosistemi – più che videogame finiti una volta per tutte – in grado, negli anni, di arricchirsi con espansioni, migliorie assortite, ritocchi, nuovi personaggi o qualsiasi bendidio il pubblico richieda. Tutto, o quasi, a fronte di un esborso extra. Che tradotto in soldoni significa sfruttare un franchise, diluirne i costi di produzione e fidelizzare una comunità a lungo termine per moltiplicare gli incassi.

L’ulteriore conferma è arrivata a inizio novembre, quando Take-Two, altro colosso del videogioco con assi come Grand Theft Auto e Red Dead Redemption nel proprio mazzo, ha dichiarato ai propri investitori che tutte le sue produzioni future si avvarranno di microtransazioni e dinamiche affini. Il tema è caldo e impone una risposta urgente: orientarsi verso una (auto)regolamentazione e quindi ricalibrare il design dei titoli e il loro modello di produzione, o a favor di cassa proseguire l’azzardo – stricto sensu – finché non intervenga qualcuno a proibirlo? “Fare, o non fare. Non c’è provare”, avrebbe detto qualcuno caro ai fan di Star Wars: un casino, più che un casinò.
Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .
Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .




