
Mark Fisher, teorico britannico, ricercatore alla Goldsmiths University e blogger conosciuto come “k-punk”, di recente si è suicidato. Quale sia stata la causa della sua morte ha una sua importanza, perché in Realismo capitalista (Produzioni Nero, trad. it. Valerio Mattioli) saggio considerato il suo manifesto filosofico, si alternano temi come la depressione, la malattia mentale e una visione claustrofobica della realtà politica e sociale contemporanea: quella di un capitalismo che non lascerebbe spazio a nessuna alternativa. L’intero libro fa riferimento a un panorama riassumibile nella massima secondo cui “è più facile immaginare la fine del mondo piuttosto che la fine del capitalismo”.
Il saggio di Fisher è interessante e intercetta un filone di scritti usciti nell’ultimo decennio in cui si mette in luce lo status quo culturale, sociale e psicologico seguito alla stagflazione degli anni ’80 e ’90 e, nei decenni successivi, alla grande recessione. Sì, perché l’umore dei singoli appartenenti a una comunità è determinato anche dagli avvenimenti economici e politici. Dagli anni ’80 in poi l’economia ha rallentato e le nostre speranze in termini di rapporto lavoro-guadagno si sono drasticamente ridimensionate. Per farla breve: siamo tristi. E ad esserlo sono soprattutto i ventenni, i trentenni e i quarantenni, cioè coloro che, avendo dinanzi a sé un futuro lavorativo più lungo e incerto, hanno più incognite da affrontare, e quindi anche più ansie corrispondenti. Il saggio di Fisher però non si limita a constatare l’ammontare del peso di questa negatività generazionale, ma si spinge verso una profilazione piuttosto precisa del colpevole: il capitalismo. Ed è in questo tracciare le linee dell’identikit economico che sorgono i problemi.
Innanzitutto nel saggio di Fisher mancano due dei pilastri necessari a qualsiasi buona argomentazione: i dubbi e le prove. Venendo a mancare i primi, l’autore non si adopera per fornire le seconde. Così il risultato è che bisognerebbe credergli sulla parola quando pone alcune correlazioni, come quella tra capitalismo e malattia mentale, in forma assiomatica: “Dobbiamo prendere i problemi di salute mentale oggi così diffusi e convertirli da una condizione di medicalizzazione a un antagonismo reale”, scrive Fisher. Come dire che la soluzione ai problemi di salute mentale è quella di protestare, di esternare il male subìto dal modello economico vigente, anziché internalizzarlo per poi patirne le conseguenze. E i riscontri? Esiste uno studio che dimostri questo nesso causale, o che sancisca l’assenza di disturbi psicologici nelle società non capitaliste? Qual era la situazione psicologica nei socialismi reali dell’Urss, della Cina di Mao o della Cuba di Fidel? E quella attuale in Nord Corea o in Venezuela? Oppure, che è uguale, come si sta (o stava) nelle società cosiddette tribali? La questione è dirimente, perché lo spirito di realtà (quello sì, “realista”) impone di considerare le alternative a ciò che si critica, affrontare la cosiddetta realpolitik (anch’essa squisitamente “reale”). Va precisato che la retorica post-strutturalista di testi come Capitalismo e schizofrenia non è considerabile come una fonte attendibile, mentre un qualche grado di oggettività ce l’hanno gli studi sulla distribuzione globale della felicità — da cui però si osserva come i Paesi abitati da persone più felici siano tutti inconfutabilmente capitalisti.
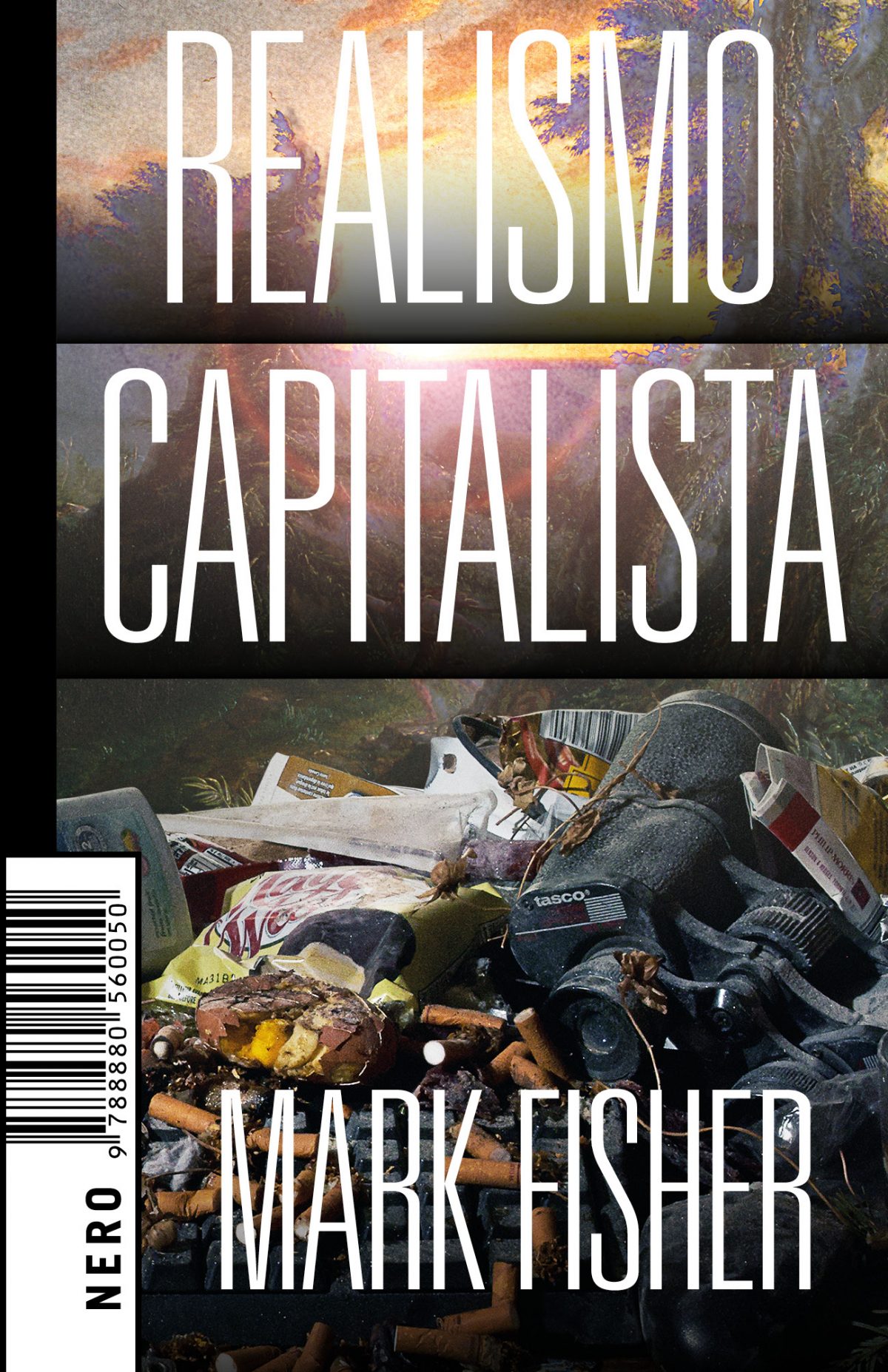
Del saggio di Fisher si parla come di un concentrato di critica culturale capace di mettere in discussione l’assunto thatcheriano secondo cui “al capitalismo non c’è alternativa”. Eppure, qui sorge un ulteriore problema, anzi due: il capitalismo non è un sistema unico, omogeneo e granitico, di conseguenza per metterlo in discussione bisognerebbe dire precisamente a cosa ci si riferisce: al capitalismo ideale delle socialdemocrazie scandinave? Al modello liberale canadese, statunitense e inglese? O magari ai ricchissimi sistemi economici che regolano le società in via di sviluppo? Forse i giganteschi accumuli di capitale dei Paesi affacciati sul Golfo Persico? Non si sa. Ed eccoci, a proposito, al secondo problema: il libro non è un libro di economia. E se è vero che ogni sistema economico diventa, volente o nolente, un modello culturale strettamente legato alla cultura e all’ideologia del luogo in cui opera, è altrettanto vero che un modello economico e politico può essere criticato seriamente solo se si trattano temi economici e politici. Si potrebbe ribattere che Fisher non era un economista, ma un teorico della cultura. E sarebbe una giusta osservazione, se non fosse che apre a una domanda un po’ impertinente: davvero un sistema enorme, sfaccettato e su cui ci sono secoli di studi economici e politologici può essere messo in discussione da cento pagine di teoria culturale, senza nessuna attenzione all’economica e alla politica?
A essere rigorosi però, dovremmo partire dall’inizio e farlo con le definizioni, quindi dire prima di tutto delle due parole scelte per titolare il saggio: realismo e capitalismo. Se la seconda è troppo generica, la prima, se possibile, è ancora più problematica. Il termine “realista” infatti è piuttosto esigente, fa riferimento a una realtà oggettiva e comprovabile (venne usato per la prima volta dai filosofi che dibattevano sugli universali; gente come Anselmo d’Aosta, per intenderci) eppure tra correlazioni deboli, brevità del trattato, assenza di studi economici e l’enorme varietà dei temi trattati, in questo manifesto politico il vocabolo appare decisamente forzato. L’uso dell’espressione “realismo capitalista”, va detto, non è nata con Fisher, ma il filosofo britannico ne ha ampliato le ambizioni connotative. Descrivendo il suo oggetto teorico, Fisher afferma che si tratta di “un’atmosfera che pervade e condiziona non solo la produzione culturale ma anche il modo in cui vengono regolati il lavoro e l’educazione, e che agisce come una specie di barriera invisibile che limita tanto il pensiero quanto l’azione”. Si potrebbe cedere al fascino della descrizione di un capitalismo simile al Panopticon, ma a essere realisti bisognerebbe osservare invece che questa “barriera invisibile che limita il pensiero e l’azione” evidentemente non impedisce di scrivere libri di questo tipo e di venderli, tradurli e diffonderli. La libertà individuale è un privilegio che, al di fuori del pur migliorabile mondo del libero mercato, è spesso ancora un miraggio (si pensi alle sorti dei blogger in Iran o a Cuba).
Insieme alla depressione, Fisher imputa al “sistema capitalista” una serie di problemi attualissimi come quello ecologico e ambientale, quello della sfiducia dei giovani nei confronti della politica, dell’apatia e così via in un lungo elenco di “danni (gli economisti direbbero “esternalità negative”). Le liste retoricamente funzionano molto bene, perché tra ritmo cadenzato e cambio repentino del tema trattato danno al lettore una forte sensazione di ampiezza dell’idea che sta alla base. Un metodo abbastanza scontato con cui Fisher convincerebbe il lettore del male intrinseco al modello economico-politico vigente. Peccato che non avvenga il passo successivo, quello in cui si dice cosa dovrebbe arrivare a sostituirlo. E per un motivo banale: un’alternativa realista, nel libro non c’è. O meglio, ci sono degli spunti interessanti, ma rimangono lontani da qualsiasi realismo, come quando Fisher scrive che bisognerebbe “spostarsi dalle priorità salariali tradizionalmente care ai sindacati per concentrarsi su quelle forme di scontento specifiche del postfordismo”. Verrebbe da essere d’accordo, ma aggiungendo immediatamente domande sui dettagli, che non troverebbero risposta.
Nel saggio purtroppo sono invece particolarmente realiste le invettive luddiste, come quella dove si sostiene (sulla base di un’esperienza in prima persona, che per l’ennesima volta bisogna considerare statisticamente rilevante nonostante non appaia come tale) che i giovani con un’istruzione superiore sarebbero così apatici da non riuscire a leggere più di qualche riga. Perché “è noioso”. Questo, secondo Fisher, risponderebbero gli studenti. E il tutto sarebbe ovviamente da imputare a un sistema dove vige una “inconciliabilità tra una generazione post-alfabetizzata e «troppo connessa per riuscire a concentrarsi» e le logiche limitanti e concentrazionarie di un sistema disciplinare in decadenza”. Altrettanto luddista è l’immancabile isolamento dei giovani dovuto alla tecnologia, come si legge a pagina 63: “L’utilizzo degli auricolari è un particolare indicativo: la musica pop non viene vissuta per il suo potenziale impatto sullo spazio pubblico, ma relegata a «edipodico» piacere consumistico e privato che ci trincera dalla socialità”. C’è un fatto divertente rispetto a queste posizioni che siedono sul confine tra luddismo e catastrofismo paternalista, e cioè che sono sempre le stesse da secoli, quindi si possono tranquillamente etichettare come reazionarie. La retorica del consumo privato che ci isolerebbe della realtà, per esempio, era la stessa quando si diffusero i quotidiani cartacei, colpevoli di isolarci sui mezzi pubblici. E anche quando si parla di cuffie e auricolari Fisher ripete slogan vecchi di decenni, come quando un quotidiano titolava: “Isolati dal mondo con le cuffie – rock”. O come Aldo Cazzullo che, parlando proprio di giovani con gli auricolari, sul Corriere sosteneva che “bisognerebbe, se proprio non si può fare a meno di girare con una cuffietta in un orecchio, tenere l’altro orecchio libero per i rumori della città, per la sorpresa di uno sconosciuto, per i suoni della vita vera”.

Uno degli spunti migliori e più precisi del saggio di Fisher è la critica ai meccanismi di produzione culturale contemporanea, dove per via di un sistema vorticoso e cinico qualsiasi posizione alternativa viene fagocitata dal consumo di massa, così come in politica ogni posizione anticapitalista appare irreale proprio perché immediatamente assorbita dall’orizzonte capitalista stesso. L’osservazione è corretta e viene dal fatto che il sistema capitalistico, quello del libero mercato, gestisce la produzione in un’ottica funzionalista: così capita che un gruppo punk autodefinitosi “antisistema” faccia successo, e non sia sufficientemente coerente da mantenere quel successo senza piegare la propria musica alle esigenze “banalizzanti” della domanda. Anche in questo senso, Fisher si dimostra un critico lontano da una coerenza davvero realista: il saggio infatti è un esempio eclatante di pastiche, fatto di rimandi a film e citazioni pop (Kurt Cobain sarebbe il simbolo di una “generazione cui ogni singola mossa era stata anticipata, tracciata, comprata e svenduta prima ancora di compiersi”) che nell’insieme creano un packaging contenutistico perfetto per il mercato culturale contemporaneo. Il libro di Fisher è per la saggistica politica post-marxista ciò che Stranger Things è stato per la serialità televisiva: un prodotto di sicuro successo, un collage ben architettato di idee passate. Alcune delle quali potrebbero anche essere condivisibili, se non fosse per la mancanza di specificità con cui sono presentate.
Ma la sovrabbondanza di citazioni pop, unita all’assenza di concretezza, fa passare il lettore dalle aspettative entusiastiche a un secco disincanto una volta finito il libro. Spiace constatare che questa inconsistenza sia la stessa descritta da Fisher quando scrive di vuoto tipico della produzione culturale obbligata all’interno dell’orizzonte di mercato. Il fatto che il saggio sia un prodotto pop perfetto – breve, accattivante, e con un hype assicurato da un packaging contenutistico tutto incentrato sulla distopia – insinua il dubbio che questo sia il motivo principale del suo successo. Perché un’operazione più seria, magari con un discorso economico rigoroso e materialista avrebbe venduto (e interessato) molto meno.
In definitiva il libro di Fisher non è un libro che mette in crisi un modello di pensiero, né un testo con le potenzialità per indurre a credere di nuovo nel futuro (tutto il contrario). È un libro che tematizza in modo più o meno cosciente il problema del secolo: si vive bene, l’occidente è in pace da decenni – e il passato dimostra che questa è una stupenda novità – ma vivere senza grandi sogni, senza proiezioni verso l’utopia, è deprimente. Una generazione di giovani occidentali, consci del fatto che ogni fantasia di “rivoluzione” si frantumerà sul muro della pragmatica politica, non può che intristirsi. L’occidente non ha prospettive, se non un razionalissimo declassamento dovuto alla fine del colonialismo e dello strapotere occidentale, una ridefinizione al ribasso del benessere sperato, a cui opporsi sembrerebbe essere inutile. In uno scenario del genere servirebbe la religione, quella dello spirito di sacrificio, della sofferenza vista come un dono divino, ma siamo troppo laici e troppo materialisti per salvare l’immaginario politico con la cristologia. Quindi? Quindi ci ubriachiamo di distopie, di incubi in cui la realtà immaginata si discosta dalla nostra lungo linee tutto sommato puntuali: la robotizzazione progressiva che indebolisce le speranze occupazionali, lo spionaggio attraverso i social network e l’imminente disastro ecologico. Insomma, il pessimismo è attuale per dei motivi ragionevoli: ma non c’è nulla di realista.
Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .
Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .




